IL GIARDINO di Gianfranco Vecchiato
 |
| Gorbaciov e Putin |
ll giardino è una componente importante per ogni abitazione perchè crea un legame diretto con l'ambiente e con le stagioni. La tipologia edilizia di gran lunga prevalente tra la popolazione del Veneto, la mia regione, è quella della casa singola o bi- tri familiare che assicura una superficie, anche se piccola, di giardino privato. In questa diffusa predilezione ci sono evidenti radici contadine di parte della popolazione che fino ad un paio di generazioni fa, viveva in piccoli paesi o nelle campagne ma c'è anche una pulsione all' individualismo. La crescita urbana che ha modificato gradualmente i contesti, ha isolato la gente all'interno di alloggi riempiti di tecnologie e poco saldati fra loro in comunità. Socialmente la progressiva immigrazione e l'invecchiamento della popolazione italiana, stanno modificando molti scenari demografici e culturali. Tra i temi attuali e ignoti alle precedenti generazioni, ci sono quelli legati alla integrazione di comunità sempre più numerose di origine e fede islamica, che hanno culture ed abitudini assai lontane dalle nostre.
Si tratta di aspetti che coinvolgono sia città che piccoli paesi, e pongono a ciascuno un profondo esame di come comportarsi se tale integrazione non avverrà assumendo una parte dei nostri costumi e stili di vita. I problemi si faranno difficili con il rischio di creare, come in vaste zone urbane di Francia delle banlieues attraversate da periodiche violenze urbane. E' un processo iniziato anche da noi e non si può non notarlo. i fenomeni diffusi di ragazzi giovanissimi che creano insicurezza nelle strade non solo periferiche, il timore nell'uscire di casa alla sera, la perdita di riferimenti religiosi che un tempo legavano le nostre comunità, un diffuso disinteresse per le questioni pubbliche, lo scadimento dell'azione politica, l'affastellarsi di burocrazie e di obiettivi economici, l'aumento delle nuove povertà, sono insieme temi sociali e culturali da affrontare nel loro insieme e riguardano tutti i Paesi, specie quelli europei, secondo le diverse sensibilità. Io ritengo che fu un errore anni or sono, da parte della UE, non riconoscere nella costituzione europea una propria radice culturale giudaico-cristiana come fondamento della sua storia. Ora chiudersi nel privato e abbandonare la partecipazione comunitaria è un errore ed un indice di malattia sociale. Da molti anni si discute di questo nel nostro continente divenuto costante mèta immigrativa. Gli Stati Uniti peraltro paiono aver imboccato la strada di un nuovo progressivo isolamento, lasciando la guida ai valori del Bene che furono così ampiamente celebrati dai suoi registi cinematografici. La vecchia Europa è dinanzi a grandi processi e cambiamenti, economici, sociali e militari. In quest'ultimo settore la storia culturale europea dovrebbe aver insegnato a non percorrere le antiche strade della contrapposizione violenta. Abbiamo pertanto oggi, tutti un problema. E andrebbe risolto insieme.
Sta avvenendo in Europa, dinanzi alla storia e non è la Russia la sola protagonista. Poteva la grande federazione di Stati che coprono due continenti, essere inclusa nella UE allargata e ci si era pensato ma la sua ampiezza creava problemi. E quindi ? La Russia da secoli è una componente della nostra cultura collettiva anche occidentale, pur se all'interno di una società che abbiamo sempre faticato a comprendere. La musica, la letteratura, il cinema, persino la politica, la tecnica e la scienza, hanno avuto nella Russia grandi interpreti. Il suo sistema politico è stato a lungo attraversato da aberrazioni. Non è stata l'unica. L'epoca degli Zar, poi il comunismo, infine una struttura autocratica. Ma fu nel XIX° secolo la Russia a sconfiggere Napoleone ed a ridefinire gli equilibri europei. Così avvenne nello scorso secolo, dopo la Grande Guerra, quando i Soviet furono fautori di una epoca tremenda e intrepida. Il popolo russo sconfisse i nazifascisti e ancora ridefinì e impose, anche brutalmente, gli equilibri europei.
Molti paesi se lo ricordano senza rimpianto. Dopo il 1991 con la fine dell'URSS e il nobel per la pace a Gorbaciov, fu la trasformazione della Russia a far ridisegnare ancora i nuovi confini europei. Ora dal 2014 e poi dal 2022 la Russia è tornata a muoversi militarmente con l'obiettivo di risistemare una parte di tali equilibri e confini. L'Ucraina resiste, intrepida e noi la ammiriamo per questo. Ancora oggi non sappiamo come finirà ma gli orizzonti sono cupi. La migliore diplomazia porterebbe al dialogo ed al confronto. Ci si parla, ci si ascolta, si sciolgono le durezze, le impuntature, i diktat e si torna a parlare con una diversa visione della Storia dei popoli, cosa rara ma qualche volta avvenuta. E ricordando i suoi insegnamenti.
 |
| Anton Cechov: Il giardino dei ciliegi |
La Potenza, la Grande Potenza, vedrà tutti gli uomini sotto terra nel volgere di qualche tempo e questi si aggiungeranno alle centinaia di migliaia di caduti già avvenuta in questi 4 anni di guerra. . Occorre tornare bambini e guardare dalle proprie finestre un angolo di Natura, anche in un piccolo giardino, vedendo che accadono continuamente cose straordinarie: un filo d'erba che cresce, un albero che dà frutti, l'alacre lavoro in un alveare, la forza del vento, della pioggia, il tuono, una giornata di sole. Cose straordinarie,queste sì di grande potenza. Lo capiamo o no che siamo un pulviscolo nell'Universo e che la vita è una cosa rara? Un summit dovrebbe svolgersi in un Giardino, meglio se piccolo, pieno di alberi, piante e animali.
Tre giorni di esercizi spirituali e di meditazioni. Ricordare le parole del santo Francesco che ringraziava la Sora nostra Madre Terra. Fermare le armi, specialmente quelle interiori. Aspettare l'alba, il sorgere del Sole per poi stringersi la mano. Vale anche nel confronto fra religioni, vale per Israele e gli Arabi, vale per quei derelitti disperati a Gaza, vale per ogni difficile appuntamento con la vita. Questo penso fosse il messaggio di qualche centinaio di idealisti in quelle barche sul mare che si diressero verso la Palestina. Papa Giovanni XXIII°, il pontefice che contribuì a disinnescare la crisi tra URSS e USA per i missili a Cuba nel 1962, promulgò nel 1963, pochi mesi prima di morire, l'enciclica "Pacem in Terris" che sottolinea l'importanza della dignità umana, dei diritti, dei doveri tra popoli. E che le controversie possano essere infine risolte col negoziato. Abitiamo la Terra ma guardiamo al Cielo. Come ogni pianta in ogni giardino.






























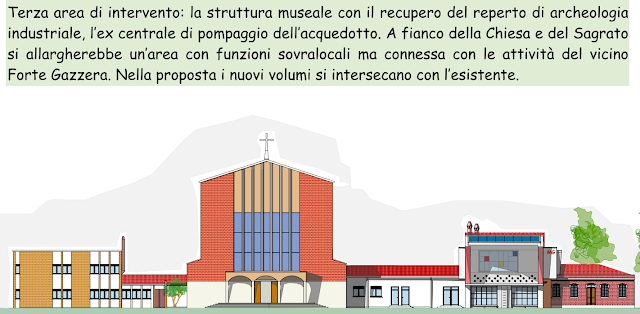





.jpg)











